La strada è di tutti, a partire dal più fragile
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE E MOBILITA' SOSTENIBILE
Prima tappa - 14/16 Ottobre 2022 - Hotel The City - Ancona
Venerdì 14 ottobre
Sabato 15 ottobre
Domenica 16 ottobre
| 18.00 – 18.30 | Accreditamento partecipanti |
| 18.30 – 20.00 | Marco Scarponi – Presentazione Fondazione Michele Scarponi |
| 8.30 – 10.00 | Paolo Gandolfi – Dal modello auto-centrico al Piano Generale della Mobilità Ciclabilez |
| 10.00 – 11.30 | Andrea Colombo – La strada è di tutti: mobilità urbana e spazio pubblico |
| 11.30 – 13.00 | Federico Bianchi – Il codice della strada. Una vita accanto ai familiari delle vittime |
| 14.30 – 16.00 | Stefano Guarnieri – Educazione alla sicurezza stradale nelle scuole. Condivisione di 10 anni di esperienza a Firenze |
| 16.00 – 17.30 | Claudia Ferron – La psicologia del traffico per la sicurezza stradale |
| 17.30 – 19.00 | Matteo Dondé – Diamo strada alle persone |
| 19.00 – 19.30 | Domande e chiusura prima giornata di lavori |
| 8.30 – 10.00 | Paolo Fedrigo – Il progetto educativo della Fondazione Michele Scarponi |
| 10.00 – 11.30 | Paola Stolfa – La città dei bambini |
| 11.30 – 12.30 | Domande e chiusura lavori |
Per avere un Paese ciclabile ci vogliono volontà, soldi, regole, tecnici, progetti e per tenere tutto insieme e trarne un buon frutto ci vuole un piano. L’Italia ha, finalmente, un piano per sviluppare la mobilità in bici: il Piano Generale della Mobilità Ciclabile, approvato dal Ministero delle Mobilità Sostenibili. “La finalità del Piano è quella di rendere, ad ogni livello, la mobilità ciclabile una componente fondamentale del sistema modale sostenibile per l’Italia, con caratteristiche di accessibilità, efficienza trasportistica ed economica, positivo impatto ambientale, strumento ad ampia accessibilità sociale e a basso costo economico.” In sintesi, la strategia si sostanzia nei seguenti punti: produrre un cambio di mentalità a favore della bici, spostare quote di mobilità urbana dall’auto alla bici, definire regole di convivenza stradale, politiche integrate sui servizi e sulla comunicazione, realizzare la Rete Ciclabile Nazionale, promuovere il cicloturismo. Le risorse messe a sistema dal Piano sono 1.154 milioni di Euro, di cui 716 per la Rete Ciclabile Nazionale e 438 per la mobilità urbana.

In Italia si stima che oltre l'80% di strade e piazze delle città oggi sia destinato alla circolazione e al parcheggio dei veicoli a motore. La mobilità sarà davvero sostenibile, allora, se, oltre a diventare a zero emissioni, restituirà anche spazio urbano alle persone, a chi si sposta a piedi, in bici o in carrozzina, agli altri usi possibili: la socialità, la cultura, il commercio, il gioco, lo sport, il verde. E' una questione di democrazia: se la strada è un bene pubblico, tutti devono poter fruirne, in libertà e sicurezza, anche se o quando non utilizzano l’automobile.

L’incidentalità stradale è un’emergenza, non foss’altro che parliamo della prima causa di morte giovanile, senza trascurare i costi socio-sanitari nei casi di gravi invalidità permanenti residuate. Per questo, lo sforzo deve essere rimesso non soltanto al Legislatore o più in generale alle istituzioni, bensì al cittadino quando interagisce con gli altri nella circolazione stradale. Il Codice della Strada è una bellissima Legge multidisciplinare che disciplina in modo chiaro e compiuto le condotte a cui uniformarsi sulla strada, nelle diverse circostanze. I numeri, scoraggianti, depongono per una grave recrudescenza del fenomeno, soprattutto con riferimento alle categorie deboli (ciclisti, motociclisti, pedoni) e alle vere cause degli incidenti (uso di alcol e droghe, soprattutto tra i giovani. Artt. 186 e 187 CdS). L’Approccio deve essere multidisciplinare. Professionisti nel campo della medicina, giurisprudenza, sociologia, ingegneria, ecc.; le
Associazioni, le Forze dell’Ordine, la Scuola, la Cittadinanza, devono tutti insieme interagire per costruire una proposta da offrire alle istituzioni e tradurre in Legge.
La diminuzione progressiva del fenomeno deve basarsi su interventi strutturali e “infrastrutturali” che ispirino a stili di vita sani, più che a interventi “repressivi”.

Nel 2011 a Firenze, il Comune, insieme all’Associazione Lorenzo Guarnieri, ha individuato all’interno del piano strategico per la sicurezza stradale 2011-2020, denominato DAVID, l’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole come una delle attività da portare avanti da Associazioni , Polizia Municipale e altri enti (principalmente 118). Il format si è evoluto nel tempo, tra alti e bassi. In questo intervento ne condividerò l’evoluzione e mi soffermerò sull’obiettivo educativo principale che, come Associazione, ci siamo posti con gli studenti delle scuole superiori: l’errata percezione del
rischio e la mancata consapevolezza del problema della
violenza stradale.

Come “funzioniamo” noi esseri umani nel sistema traffico? Quale ruolo riveste il “fattore umano” nell’incidentalità stradale? Come potenziare la sicurezza stradale? In questo intervento partiremo da uno sguardo alle statistiche italiane sull’incidentalità stradale, esploreremo insieme la complessità del nostro funzionamento in strada, delle risorse e dei limiti che ci caratterizzano, parleremo di reazione ad un pericolo, di
attenzione, di percezione del rischio. Rifletteremo infine sull’importanza di educare bambini e ragazzi alla sicurezza stradale per poter salvaguardare il loro diritto di crescere, prevenire l’incidentalità stradale e promuovere lo sviluppo di una cultura della sicurezza e della mobilità sostenibile nelle nuove generazioni.

Troppo spesso nelle città si pensa che la strada sia proprietà delle automobili. In realtà, è uno spazio urbano in cui devono convivere diverse categorie di utenti, dal pedone al ciclista, dall’automobilista al motociclista.
L’effetto di questa errata convinzione è un uso della strada aggressivo soprattutto da parte degli automobilisti, con conseguenze negative sul piano della sicurezza, della qualità ambientale ed anche dal punto di vista educativo.
Ridurre la velocità e il numero dei veicoli a motore significa ridurre lo spazio ad essi dedicato in contesti consolidati dove tale spazio è preziosissimo. A favore di marciapiedi più ampi e accessibili, di percorsi ciclabili, del verde urbano e della forestazione, degli spazi per le persone come giochi per i bambini, panchine e tavoli per tornare a vivere lo spazio pubblico, per creare nuovi luoghi di socializzazione, per ri-dare strada alle persone.

L’obiettivo della Fondazione Michele Scarponi è quello di proporre un approccio educativo trasversale alla problematica della mobilità, per far nascere una cultura della sostenibilità che coniuga aspetti ambientali, sociali, economici ed etici. Per far questo dobbiamo andare oltre alle campagne di comunicazione e lavorare sulla scala valoriale delle persone, ragionare sul concetto di qualità di vita, mettere in discussione modelli di sviluppo e di consumo fin qui assunti. Proporre un progetto di educazione alla sostenibilità significa promuovere un percorso educativo attraverso il quale le persone possano
scegliere uno stile di vita orientato dai principi dello sviluppo sostenibile, meno impattante per il Pianeta e più rispettoso delle persone che lo abitano. Il percorso di educazione alla mobilità sostenibile partirà dalle scuole in quanto presidi e volani per una mobilità differente. Le scuole sono inserite fisicamente nel tessuto urbano, incidono sulla mobilità nel percorso casa-scuola e hanno la possibilità di veicolare messaggi importanti attraverso studenti e insegnanti. In questo intervento conosceremo le caratteristiche e i principi fondamentali da considerare in un progetto di educazione alla mobilità sostenibile e faremo delle proposte educative per le scuole.
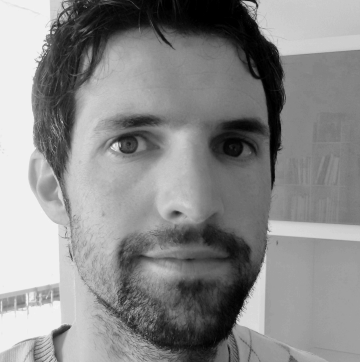
Il progetto “Città dei Bambini”, oggi riprodotto ed esportato in molte città italiane e nel Mondo, nasce a Fano nel 1991 con l'obiettivo di migliorare il rapporto bambino-città, per perseguire il benessere dei cittadini più giovani nel contesto urbano.
L'impegno dell'amministrazione è quello di restituire ai bambini il loro pieno esercizio di cittadinanza, l'opportunità di riappropriarsi degli spazi pubblici e di potersi muovere nella città in autonomia e sicurezza.
Una città a misura di bambino è una città che non lascia indietro nessuno; è una città accessibile e inclusiva, attenta a tutte le fasce “deboli”, come diversamente abili e anziani.
Il programma Città dei bambini rappresenta innanzitutto una scelta politica e culturale; una scelta di trasformazione della città nella direzione della sostenibilità che pone il bambino come punto di riferimento delle scelte politiche e induce a rivedere i convenzionali parametri di programmazione e di
governance.

Precedente
Successivo